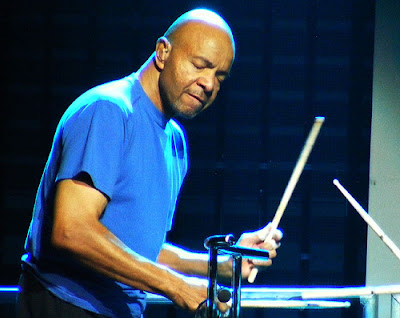THE MAGICIAN’S BIRTHDAY:
TEN YEARS OF DARK COMPANION RECORDS
Di Andrea Pintelli
Dieci anni. Per un’etichetta discografica indipendente,
oggigiorno, sono tanti. Per chi incessantemente promuove cultura, oltre a
produrre dischi, sono tantissimi. Dark Companion Records, splendida
creatura del funambolico e inesauribile patron Max Marchini, è la
festeggiata. Per celebrarla, alle ore 21.00 dei giorni 12, 13, 14 dicembre 2025
si terranno all’auditorium Santa Margherita di Piacenza concerti, jam,
showcases, in cui si avrà l’opportunità di incontrare, condividere, respirare
l’armonia, l’eccellenza e l’importanza che da sempre la contraddistinguono. Per
cui, siete (siamo) tutti invitati a partecipare: estimatori o neofiti, in ogni
caso mossi dal demone della curiosità e alla ricerca della grande bellezza.

E allora tanti auguri di buon compleanno, in magia, in
continuità, in qualità. Già perché le sue fila sono popolate di artisti di
livello mondiale, che hanno in sé le caratteristiche di questi tre sostantivi.
Inutile elencarli tutti, sta a voi visitare l’esauriente sito internet, il cui
indirizzo è riportato in calce a quest’articolo, per trovarli, conoscere,
viverli attraverso le loro opere. Esso si apre con una frase che non lascia
spazio a dubbi: “Esplorare la musica con una qualità audio senza compromessi”.
E poi: “L'obiettivo di Dark Companion è quello di riunire l'eccellenza
musicale di un'ampia gamma di generi: dalla canzone d'autore al folk, dalla
musica classica contemporanea al jazz, dalla musica sperimentale alla musica
classica, sia di tradizione occidentale che orientale. Il suono è tutto.
Crediamo che il klang sia al centro della musica, quindi dedichiamo
tutte le nostre energie a garantire che i nostri dischi, sia in vinile che in
CD, offrano la qualità sonora più vibrante, realistica e di alta qualità possibile.”
Tutto ciò è reso possibile, anche, grazie ad Alberto Callegari,
mirabolante ingegnere del suono dell’Elfo Studio, di Tavernago che da
sempre è partner operativo.

Quattro nuovi lavori sono stati pubblicati contemporaneamente in
occasione di tale ricorrenza. Quattro signori dischi. Iniziamo da Priska,
artista (cantante, compositrice, polistrumentista) di origine francese
trapiantata in Friuli-Venezia Giulia, giunta alla quinta incisione, seconda con
l’etichetta piacentina. Intitolato “Popurì” ha come protagonisti “la sua
scrittura delicata, capace di evocare scene intime ed evocative e la sua voce
vellutata e ambrata, che ricorda Bridget St. John e Patty Waters. Priska
racconta storie inquietanti e profonde e questo nuovo album, cantato e scritto
in diverse lingue, rappresenta un chiaro passo avanti nel suo straordinario
talento compositivo. Undici composizioni originali più una toccante cover di Air De Neige, capolavoro di Sergio
Endrigo.” In ordine sparso: E Invece Sono
qui, straniante; Au Revoir,
giocosa; Scum, intensa; Samurai, pop; Prisonniers, delicata; Celle
d’Hier, fosca; Orion, dolcissima;
Mon Ovni, carezzevole; Can You See Me, affettuosa; Elle, intima; Air De Neige, eterna; Frank,
personale.
Passiamo a “Chansons d’Automne”, nuovo
album del leggendario John Greaves. “Si
tratta di (quindici) canzoni con una sottile vena di malinconia, eseguite
insieme al suo compagno di tante avventure, Lurent Valero alla viola, e alla brillante
giovane violinista Mirabelle Gilis, mentre l'ex Henry Cow suona il pianoforte e
canta. La sua voce è davvero incredibile, come sabbia e colla, intensamente
teatrale ed espressiva. I brani si susseguono, alternando nuove composizioni a
brani scritti ora con Peter Blegvad o basati su testi di poeti amati, come
Apollinaire. Un album memorabile, intenso, diretto e delicato la cui atmosfera
è ben descritta dalla copertina.” Brother
Fox, profonda; Le Guetteur
Mélanconique, teatrale; Au Lac de tes
Yeux Très Profonds, impressionista; The
Bee Dream, onirica; Le Pont Mirabeau,
poetica; Avalanche, struggente; Saturne, emozionante; Summer on Ice, visionaria; Colloque Sentimental, affettiva; Je Pense à Toi Mon Lou, passionale; The Price We Pay, d’altrove; Swelling Valley, allucinata; Chanson d’Automn e, malinconica; Séguidille, veemente; Mutations, spassosa.
Craig Fortnam &
Laurent Valero, membri della maestosa North Sea Radio Orchestra, concretizzano
la loro collaborazione con “Empty Vessels”, ossia un debutto memorabile. Craig
e Laurent sono “un nuovo duo dalla creatività esplosiva e dallo straordinario livello
musicale che esplora i confini tra musica rinascimentale, classica, medievale,
folk e contemporanea. Come di consueto per Craig Fortnam, meglio conosciuto
come la mente dietro la North Sea Radio Orchestra, e Laurent Valero, anche lui
membro dell'ensemble in occasione dell'acclamato tributo alla musica di Robert
Wyatt, Folly Bololey, pubblicato da Dark Companion nel 2019, e collaboratore di
John Greaves in numerose registrazioni e performance dal vivo. Registrato in
Inghilterra e in Italia presso i leggendari Elfo Studios, dove l'album è stato
anche masterizzato dallo stesso Alberto Callegari, Empty Vessels ospita
un'altra protagonista dell'avventura di Wyatt, la cantante Annie Barbazza, che
ha cantato magistralmente con la sua voce ammaliante in due splendidi brani. La
ghironda è eseguita da James Larcombe e conferisce una speciale atmosfera
medievale ad alcuni brani straordinari. La musica è davvero fantastica: offre
un mix unico di generi e stili, come ormai è diventato un marchio di fabbrica
del geniale compositore inglese, ed è sempre intrigante. Un mix che richiama la
musica folk elisabettiana e medievale, unito alla scrittura di canzoni
contemporanee.” In The Silent Places, elettronica; White
Swan, bucolica; Cries Of London,
weirdy; Bourée, trobadorica; Inky, splendida; Cathedral, inusuale; Letting
Go Not Letting Go, fiastroccando; Empty
Vessels, immaginifica; In The Magic
Number, esoterica; Snowthing,
magica.
Ultimo, ma non ultimo, “Winter Tales” di capitan Max Marchini.
Più che un disco, un tesoro fatto di gemme, a cominciare dalla copertina,
firmata da Max stesso. Le sue parole a tal proposito: “Cinque anni dopo
l'uscita di "Songs From The Harbour", per celebrare il decimo
anniversario della Dark Companion Records nel peggior modo possibile, ecco una
seconda raccolta di schizzi musicali, idee o, più onestamente, solisistiche
sessioni notturne durante le quali raccolgo i miei pochi pensieri, esplorando
suoni, riverberi e rifrazioni elettroacustiche. Noto che alcune di queste
canzoni, al di là del loro consueto intento introspettivo e malinconico, in
qualche modo richiamano l'inverno o il tardo autunno, forse perché sono nato
durante una forte nevicata in un nebbioso novembre di secoli fa. Se riesco a
trasmettervi questa sensazione, significa che questo album ha avuto uno scopo.
In questi dieci anni di attività, la Dark Companion è cresciuta e grazie ad
essa ho incontrato persone meravigliose, musicisti dalla curiosità insaziabile,
straordinari ingegneri del suono, fotografi, amanti della musica, anime piene
di desiderio e grazia. Ed è a tutti loro che è dedicato questo mio umile lavoro.”
In dettaglio: Hail From The Mountains, sostanziale; Green Adventures Part I, esplorativa; Ultramarine Woodland, stanziale; BergKristall, surreale; Morning
Haze, caliginosa; Green Adventures
Part II, ricognitiva; The Forest
Dream Of Awakening, fiabesca; Celestial
Evenings, sperimentale; Fata Morgana,
stregata; Green Adventures Part III,
indagatoria; The Horned God Of The
Witches, oscura; Of Evenings Without
You, mesta; Melting Snowflakes,
visionaria; Green Adventures Part IV,
orientativa.
Quattro opere diversissime fra loro, ma accomunate da quanto
detto sopra, in fiero e autentico stile Dark Companion.
Abbracci diffusi.



.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)