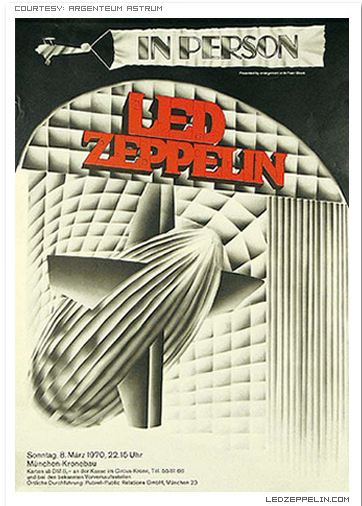Compie gli anni Billy Sherwood, nato a Las Vegas il 14 marzo 1965, bassista e chitarrista statunitense noto per essere membro dello storico gruppo progressive Yes.
Sherwood crebbe in una famiglia di musicisti: suo padre Bobby era un direttore di orchestra jazz, sua madre Phyllis una cantante e batterista, e suo fratello Michael pianista, tastierista e cantante.
La sua carriera musicale iniziò con la band chiamata Lodgic, fondata col fratello Michael a Las Vegas. Billy era bassista e cantante, Michael tastierista e cantante. Con loro suonavano anche Guy Allison (tastiere), Jimmy Haun (chitarra) e Gary Starns (batteria). Nel 1980 si trasferirono a Los Angeles, e nel 1986 riuscirono a pubblicare il loro album di debutto, “Nomadic Sands”.
Quando i Lodgic si sciolsero, Sherwood fondò un nuovo gruppo con Guy Allison, i World Trade, per il quale reclutarono anche il chitarrista Bruce Gowdy e il batterista Mark T. Williams. L'album di debutto omonimo fu pubblicato nel 1989, e di nuovo Sherwood ne fu anche tecnico del suono e del mixaggio e produttore, oltre che bassista e cantante.
In quel periodo, piuttosto casualmente, Sherwood e Gowdy furono invitati a suonare con Chris Squire, Alan White e Tony Kaye degli Yes. Il cantante Jon Anderson e il chitarrista Trevor Rabin erano in procinto di lasciare il gruppo, e per Sherwood e Gowdy si profilò l'opportunità di sostituirli. Sempre in quel periodo, Sherwood collaborò come produttore discografico nell'album “March or Die” dei Motörhead. Nel 1993-1994, durante il tour dell'album Talk, Sherwood tornò a suonare con gli Yes, questa volta come musicista aggiuntivo (alle chitarre e alle tastiere) per le esibizioni dal vivo.
Dopo “Keys to Ascension” e “Keys to Ascension 2”, nell'estate del 1996 Rick Wakeman abbandonò (per l'ennesima volta nella sua carriera) gli Yes. Questo evento portò Sherwood a diventare per la prima volta membro ufficiale del gruppo per la realizzazione dell'album “Open Your Eyes” (1997), che conteneva molti brani scritti da Sherwood e Squire negli anni precedenti per il "Chris Squire Experiment". In “Open Your Eyes” Sherwood era tastierista e secondo chitarrista (il ruolo di chitarra solista era in quel momento coperto da Steve Howe, che era tornato al suo posto dopo la parentesi degli Yes con Trevor Rabin). Nella primavera del 1997 per concludere le session dell'album e per il loro successivo tour promozionale, gli Yes acquisirono un nuovo tastierista, Igor Khoroshev, lasciando il posto a Sherwood alla chitarra e alle seconde voci.
Fu registrata qualche demo, ma il progetto, in questi termini, non fu mai realizzato; Anderson e Rabin, tra l'altro, non abbandonarono. Come Trevor Horn prima di lui, Sherwood non era molto attratto dalla prospettiva di sostituire Anderson come front-man del gruppo; tuttavia, Sherwood divenne buon amico di Squire, con cui diede vita a un progetto inizialmente chiamato Chris Squire Experiment, da cui sarebbe derivato, qualche anno dopo, il gruppo Conspiracy.
Durante il tour di “The Ladder” fu registrato e filmato un concerto, da cui furono tratti un doppio CD dal vivo e un DVD, entrambi col titolo “House of Yes”. Una settimana dopo al termine del tour del 2003 fu annunciato che Sherwood non era più negli Yes.
Già dai primi anni Novanta, Sherwood collaborò in maniera costante con John Wetton, nel 2011 prese parte come autore all'album “Raised in Captivity”, dopodiché il rapporto si interruppe.
Nell'estate del 2015 tornò di nuovo con gli Yes, stavolta come bassista, rimpiazzando il fondatore del gruppo Chris Squire che era appena deceduto, diventando anche autore di alcuni brani della band.
A partire dal 2017 entra negli Asia come membro ufficiale, dove sostituisce il suo amico John Wetton.
Nel 2020 Sherwood decide di porre fine al gruppo Conspiracy, del quale era diventato leader; alcuni mesi dopo annuncia la nascita di un nuovo supergruppo, gli Arc of Life.


















.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)